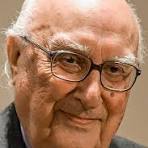
In questi opachi frangenti, un po’ di luce può forse venire dalla letteratura e dalla connessa critica letteraria (quando non sia ripetitiva né altezzosa né snobistica).
E però, oggi, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, si vuole considerare il nesso tra letteratura e giornalismo (in un’ottica post e anti crociana), quale si evidenzia nell’opera di questo geniale scrittore siciliano, che ha affrontato più volte, apertis verbis, nella sua qualità di intellettuale di sinistra, senza ambiguità alcuna, il dramma – purtroppo, ancora attualissimo – dell’emigrazione e dei migranti, sia in scritti giornalistici, che si segnalano per l’assoluta pregnanza dei contenuti e per l’asciuttezza esemplare dello stile (codice giornalistico), sia in romanzi di grande rilevanza stilistica e conoscitiva (codice narrativo).
Non è peraltro insolito che Camilleri recuperi in un romanzo (a dispetto di don Benedetto) temi, situazioni narrative, personaggi, stilemi già utilizzati in articoli di giornale e viceversa, operando un passaggio – una transcodificazione, se si vuole –, dai codici giornalistici ai codici narrativi e viceversa, secondo modalità che sono ampiamente trattate e codificate dalla Letteratura Comparata. Ma càpita, altresì, che il Vigatese utilizzi, in uno stesso testo, codici giornalistici e narrativi, a conferma – se ne fosse bisogno – della sua estrema libertà espressiva, che non arretra di fronte ad alcuna effrazione del codice o violazione della norma, nell’intento di dare forza ai suoi sentimenti e alle sue idee.
La prima, accorata, partecipe denuncia della responsabilità della destra di governo (Gruppi di AN e Lega) nei confronti degli immigrati, contro cui si aizza «l’ostilità dei cittadini», «soffiando sul fuoco» di incidenti che potrebbero essere evitati con un uso accorto delle forze dell’ordine, è in un articolo del 2006 (La primavera di Micromega, in «Micromega» n. 3, marzo 2006), in cui l’io narrante è lo stesso commissario Montalbano, come a volere sancire la commistione del codice narrativo col codice giornalistico Vi si evidenziano efficacemente, nei modi argomentativi e sintetici della scrittura giornalistica, ma anche col ricorso a moduli narrativi (le sequenze dialogiche, nella fattispecie), i dati disastrosi dell’emigrazione: a) il numero considerevole degli immigrati che arrivano a Lampedusa («Ieri […] sono arrivati col postale 250 extracomunitari»); b) la notevole presenza tra costoro di «Fimmini con picciliddri, anziani, picciotti»; c) l’incomprensione della tragedia da parte degli italiani o di una parte di loro («Ora io mi domando e dico: ma con quei cinque milioni ognuno di loro, al paese loro, non avrebbe potuto camparci per qualche annata?»); d) «l’infame [legge] Bossi-Fini» e l’altrettanto infame Fini-Giovanardi; e) il sospetto, propalato dalla destra di governo, secondo cui «c’è la possibilità che con i barconi degli immigrati clandestini arrivino da noi anche i terroristi»; f) la delittuosa azione degli scafisti («corre voce che due o tre passeggeri siano stati gettati in mare dagli scafisti»).
Ma altrettanto – se non più risentita – è la condanna dell’azione governativa, presente nell’Appello contro il ritorno delle leggi razziali in Europa, firmato da Camilleri e da altri intellettuali democratici, su «Micromega» del 2 luglio 2009:
Il governo Berlusconi, agitando il pretesto della sicurezza, ha imposto al Parlamento, di cui ha il pieno controllo, l’adozione di norme discriminatorie nei confronti degli immigrati, quali in Europa non si vedevano dai tempi delle leggi razziali. È stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non più gli ebrei bensì la popolazione degli immigrati irregolari, che conta centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti previsti dalle leggi razziali, come il divieto dei matrimoni misti.
Si collega a questo, il successivo appello del 14 ottobre 2009, su «Micromega.net», intitolato La difesa dei diritti dei migranti è la difesa della democrazia:
L’introduzione del reato di immigrazione clandestina, il prolungamento della detenzione amministrativa e l’ulteriore limitazione della possibilità per i migranti di accedere a servizi fondamentali accentuano in maniera drammatica la curvatura proibizionista e repressiva delle politiche migratorie del nostro paese: […] Così si apre la strada […] a una società razzista, dominata dall’intolleranza e dall’odio. Il nostro paese ha già vissuto la vergogna delle leggi razziali: non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo.
Da ciò, l’ampio Manifesto dei vecchi democratici per la realizzazione della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza antifascista, su «Micromega», 8/2012. in cui tra le altre cose, si chiede «l’abrogazione delle leggi su droga e clandestinità nelle versioni attuali che intasano le carceri».
L’ultima, decisiva presa di posizione in merito è in quella sorta di autoritratto (Camilleri sono) pubblicato su «Micromega» nel maggio del 2018:
Ma non ho molta fiducia che dalla società civile possa nascere qualcosa. […] Io vedo una mutazione genetica nel paese, al punto che mi chiedo se l’Italia non sia stata conquistata dai marziani […]. Ecco sembrano umani ma non lo sono […].L’idea di chiudere i porti è un’infamia, l’idea di dire alla Guardia Costiera: «Se ricevete un SOS rispondete: “Rivolgetevi a Tripoli”» è un’altra infamia. E infatti il comandante della Guardia Costiera ha dichiarato con grande civiltà: «Noi risponderemo a qualsiasi SOS».
Nell’ambito della narrativa, la tematica dell’emigrazione appare nei romanzi Il giro di boa del 2003, L’altro capo del filo del 2016 e Ora dimmi di te (che è una lettera a una nipotina) del 2018.
Ma di ciò la prossima volta.