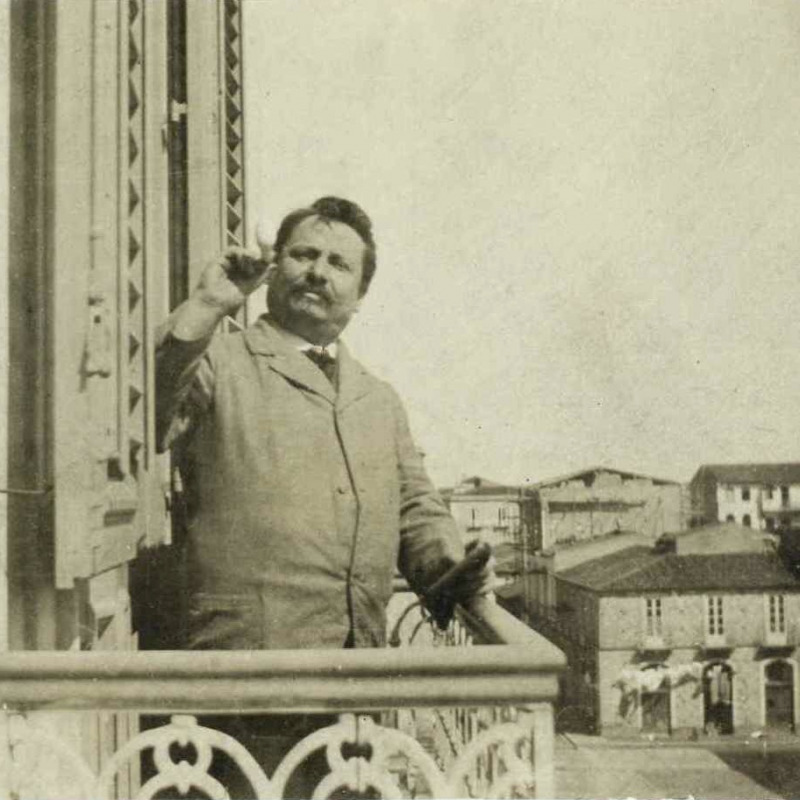
Non fa male guardare indietro, ogni tanto: per non dimenticare e magari per trovare stimoli a fare meglio per sé e per gli altri.
A Messina, invero, negli ultimi quarant’anni non è cambiato quasi nulla. Il meglio della città si era, infatti, visto, per unanime convinzione, negli anni Cinquanta-Sessanta: l’espansione commerciale della produzione agrumaria e delle essenze con i Bosurgi (unici “eredi” della Sanderson, dopo il terremoto del 1908); lo sviluppo dell’attività industriale, propiziato dai Cantieri Navali Rodriguez (dove, nel 1956, fu varata la “Freccia del Sole”, il primo aliscafo del mondo); l’incremento del turismo, con la Fiera, la Rassegna cinematografica, l’«Irrera a Mare»; l’avanzamento culturale segnato dalla Libreria dell’Ospe, dall’Accademia della Scocca, dalla «brigata» degli amici (Pugliatti e La Pira in specie) di Quasimodo, vincitore del premio Nobel nel 1959.
Dagli anni Ottanta in avanti, si avviò, per converso, nella città dello Stretto, un generale livellamento-arretramento, segnato dalla stagnazione politico-amministrativa (con una sfilza ininterrotta di sindaci democristiani e/o di centrodestra, interrotta solo dalle sindacature Providenti, Buzzanca e Genovese, poi confluito in Forza Italia), dall’arretramento dell’Università su posizioni “baronali” e familistiche, che la distanziarono enormemente (con le dovute eccezioni) dai traguardi scientifici e didattici del ventennio precedente, dalla crescita a dismisura delle attività terziarie (con il conseguente prevalere degli egotici, regressivi comportamenti piccoloborghesi della maggior parte della popolazione messinese). Né – bisogna ammetterlo – le forze politiche più responsabili seppero smuovere le acque, attirare i giovani, proporre alternative: si rilevarono, casomai, capaci di gestire le solite, stentate pratiche burocratiche, con qualche rara eccezione sia pure (De Pasquale, Bottari).
E oggi? Qualche piccolo segno di risveglio c’è, fortunatamente, ma in una struttura tuttavia lenta, pachidermica e attardata: va, dunque, opportunamente evidenziato, insieme con i ritardi e le inadempienze antiche e moderne.
Permane, purtroppo, in città, il ristagno connesso con l’assenza di ogni attività industriale, con la penuria dell’artigianato, con la drammatica assenza di posti di lavoro che spinge i giovani messinesi a lasciare il «loco natio» per realizzarsi altrove: si legge, nelle ricorrenti inchieste giornalistiche nazionali, che Messina è, nell’ultimo trentennio, la città più spopolata d’Italia.
Fa sperare certamente la ripresa, negli ultimi anni, del turismo di massa, culminata con l’assegnazione, nel 2025, della Bandiera blu alla Città Metropolitana per le acque balneari e i servizi offerti negli undici chilometri della costa: notevole anche la sempre più massiccia presenza nel porto di navi da passeggeri, nazionali e internazionali.
Tra le poche positività messinesi del Terzo Millennio non si può non ricordare, infine, la fioritura eccezionale delle attività sportive (nonostante la retrocessione dell’ACR Messina) e delle associazioni culturali, insieme con la presenza di un gran numero di poeti, alcuni dei quali mostrano le giuste credenziali per affermarsi anche fuori degli angusti limiti provinciali. Di recente si assiste, peraltro, ad un risveglio, anche nella città dello Stretto, della partecipazione spontanea a manifestazioni di massa in difesa dello sviluppo sostenibile, contro il famigerato ponte di Salvini e contro la politica rinunciataria del governo relativamente alle guerre in atto e al genocidio dei palestinesi a Gaza.
Vanno, inoltre, nel senso giusto i riconoscimenti ufficiali di alcuni apprezzati Licei e Istituti Superiori della città e della provincia, che si segnalano per le innovazioni didattiche e formative: segno tangibile di un rinnovamento in atto nel settore cruciale della scuola. Più timidi segnali di cambiamento vengono dall’Università, dove solo due professori della famosa ex Facoltà di Legge primeggiano nel giornalismo nazionale e negli alti livelli istituzionali. Resistono, tuttavia, nel conformismo generale, i paladini dell’Università basata sul merito e sulla trasparenza: qualcuno di loro consegue, addirittura, risultati giudicati innovativi in Italia e all’estero, ma non incide più di tanto in loco (forse perché ha la schiena troppo dritta): è un mondo più di altri complesso, invero, quello accademico, ma non c’è dubbio che sia, anch’esso, in movimento, da qualche anno. Speriamo
Non si può, tra l’altro, sottacere che, nel soporoso clima dell’incipiente Terzo Millennio, si segnalarono, a Messina, gruppi minoritari di giovani e meno giovani democratici (perlopiù di sinistra, ma lontani dai partiti) che si opposero con operazioni concrete, al dilagante conformismo, secondato da poteri viepiù arretrati e insipienti. D’altra parte, il meglio – a Messina e non solo a Messina – viene sempre dalle minoranze.
Alcuni di questi volenterosi, legati soprattutto da vincoli di amicizia, diedero vita, in occasione del centenario del Terremoto, a un gruppo spontaneo, battezzato «100 messinesi per Messina 2Mila8» che proponeva un effettivo risanamento delle piaghe strutturali ancora aperte da quell’immane sfacelo nella città.
In tale contesto, costoro organizzarono assemblee popolari, incontri con gli studenti e manifestazioni politiche per ricordare, ai messinesi e alle distratte maestranze politiche e culturali della città, la presenza di Pascoli (tra il 1898 e il 1902) nell’Università di Messina e sollecitare l’acquisto da parte dell’Università e/o del Comune della casa in cui abitò, con la sorella e col cane Gullì, il grande poeta: un appartamento del Palazzo Sturiale sito in Via Risorgimento 158 (definito «il più bell’alloggio di tutta Messina»), per farne la Casa-Museo del Centro Studi Giovanni Pascoli di Messina.
Tale meritorio impegno non produsse, invero, alcun effetto positivo, se non quello del rifacimento, ad opera del Comune, della facciata del Palazzo suddetto, e di una targa in marmo affissa accanto al portone per ricordare l’evento. Glorie messinesi.
Questo gruppo di amici, in cui il prof. Piero Chillé finì con l’avere una effettiva (non richiesta) primazìa, ha pure collaborato – e collabora – alla celebrazione annuale di Giuseppe Micheli, il deputato parmense che, dopo il terremoto del 1908, giunse, tra i primi, a Messina, portando aiuto alla popolazione gravemente provata, nonché alla commemorazione di Boris Giuliano, dirigente della Polizia di Stato, che visse a lungo a Messina, dopo la seconda guerra mondiale, e fu ucciso in servizio a Palermo nel 1979 da un killer mafioso.
Questi ultimi fatti innovativi e gli altri sopra indicati sono, certamente, pochi e minori, nel grave contesto internazionale in cui viviamo, ma sono pure, a loro modo, portatori di significative linee di tendenza, da non ignorare: l’associazionismo democratico, la partecipazione attiva allo sviluppo sociale, la difesa dei deboli, dei valori costituzionali e della pace sembrano crescere viepiù tra i messinesi.
Certo, Messina resta, purtroppo, una periferica provincia dell’Italia, a sua volta «provincia dell’impero» (americano), per dirla con Umberto Eco: provincia della provincia, dunque. Ma di ciò, in altra occasione.